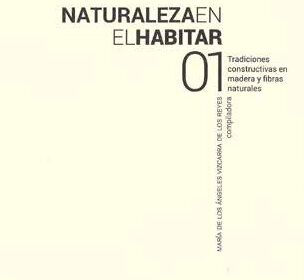Claudio Varagnoli
Invited editor
CC BY-NC-ND
Es arquitecto y catedrático italiano. Licenciado en Arquitectura por la Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con una disertación sobre el restauro en el siglo XVIII, en 1987 consigue el título de doctor en “Conservazione dei beni architettonici” por la Università “La Sapienza” de Roma. Desde 1990 se dedica a la didáctica y a la investigación en el Dipartimento di Architettura de la Università di Chieti-Pescara, donde desde 2001 es catedrático de “Restauración arquitectónica” y de “Teoría e historia de la restauración”. En esta misma universidad, ha coordinado los cursos de doctorato en restauro, y un master en “Conservazione e recupero dell’edilizia storica” (2005-2008). Desde 2013, es profesor de “Teoría y práctica de la Restauración” en la Escuela Italiana de Arqueología en Atenas. Es responsable de convenios internacionales con Universidades de México (UNAM) y España (Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Zaragoza).
Ha supervisado varias intervenciones de restauración, como en el conjunto del Viale del Foro Italico en Roma; participó en los programas de rehabilitación de los centros históricos en Abruzzo después del terremoto de 2009. Ha publicado estudios sobre la arquitectura del siglo XVIII y sobre la historia del restauro en Italia. Además, es autor de aportaciones sobre teoría del restauro, con una especial atención hacia el tema de la autenticidad, y sobre la relación entre la proyectación contemporánea y la conservación.
Il tema della ricostruzione assume oggi connotati diversi da quanto elaborato dalla cultura classica del restauro. Il secolo che si è aperto con la sanguinosa distruzione delle Twin Towers a New York ed è proseguito con le distruzioni dei monumenti dell’Afghanistan, di Palmira e della Siria getta nuova luce sul significato del ricostruire dopo una tragedia.
La ricostruzione di cui si parla in questo numero di Gremium è quella che cerca di restituire un edificio allo stato antecedente l’evento distruttivo, generalmente rispettando almeno il sito e le qualità formali originarie. Com’è noto, si tratta di una pratica che si è tradotta molto spesso nella realizzazione di repliche che hanno preteso di ripetere tecniche, materiali, mestieri di altre epoche storiche. Di qui il carattere fortemente inattuale di queste realizzazioni, che non convincono il conoscitore e l’esperto, né riescono ad affascinare il visitatore. Alois Riegl aveva segnalato, in Der moderne Denkmalkultus (1903), l’importanza della percezione dell’antichità in un edificio (Alteswert). Questa alterità dell’opera rispetto al contesto attuale è alla base delle principali correnti di pensiero che hanno forgiato l’idea di restauro nel Novecento. Il documento che sintetizza e porta a sistemazione normativa tali tendenze, la Charte de Venise, ha cercato di porre fine alla pratica della ricostruzione, ricorrente nei lunghi anni del secondo dopoguerra.
Tuttavia l’attuale contesto culturale e sociale ci guida ad una riconsiderazione di quanto sin qui operato. La rilettura globale dello sforzo compiuto da vari paesi coinvolti nelle guerre del Novecento mostrano che le ricostruzioni sono sempre state caricate di significati umani e spirituali che vanno al di là della semplice materia. La volontà dei polacchi di reagire alla strategia di annullamento messa in atto contro il loro paese, la paziente ricomposizione di minuscoli frammenti risultanti dai bombardamenti o dai terremoti delle chiese italiane, sono parte integrante del risultato
finale, che non può essere quindi valutato soltanto come “copia” o anastilosi.
Naturalmente il termine ricostruzione copre un arco di significati molto vasto. Si va dalle esperienze archeologiche finalizzate alla comprensione didattica o scientifica – dalla Grecia antica al Messico di Teotihuacán – alle riparazioni e sostituzioni da effettuare dopo un terremoto, con l’obiettivo di salvaguardare le vite umane; alla produzione di veri e propri cloni, pensati con intento didattico per restituire l’esperienza di un’opera perduta o lontana.
La cultura tedesca distingue tra la ricostruzione mirata allo studio di edifici perduti o ridotti allo stato frammentario, da una nuova edificazione che ingloba in vario modo i resti precedenti, replicando le parti mancanti o restituendone solo i tratti essenziali, riletti con la consapevolezza della distanza storica. Le grandi ricostruzioni di Hans Döllgast, Josef Weidemann e altri a Monaco di Baviera sono esempi che fanno propri i significati morali del contesto in cui sono nate, ma senza negare l’opera di partenza. Di qui il profondo valore interpretativo di ogni ricostruzione: che nasce da un’ibridazione tra epoche diverse e per questo tanto più carica di significati.
L’atto del ricostruire non può essere scisso, come si è detto, dalle motivazioni che lo guidano: quindi per valutare un’opera di ricostruzione bisognerà rapportarla all’evento distruttivo che ne è all’origine. La ricostruzione post-bellica, ad esempio, può realizzarsi nella speranza che un simile episodio non si verifichi più. La situazione cambia nella ricostruzione post-sismica, quando ogni intervento, deve mettere in conto la possibilità di nuove scosse e quindi di nuove distruzioni, ponendo la salvaguardia della vita umana in primo piano. Questo obbliga a ripensare l’edificio danneggiato, tenendo in massimo conto la sua autenticità, ma certamente verificando le sue caratteristiche strutturali. Lo stesso vale nel caso degli altri eventi calamitosi, come frane, incendi, maremoti, atti di terrorismo. Né va dimenticata la distruzione indotta dall’oblio volontario: è quanto succede nei casi di memorie “negative” o portatrici di conflitto, come gli edifici e le testimonianze delle dittature e dei regimi autoritari in genere. Ma anche la speculazione immobiliare può portare ai processi di distruzione/ricostruzione, come mostrano le vicende di tante città del continente americano in particolare, o i processi di rinnovamento attivati in Russia dopo la caduta del regime sovietico.
Lasciare questo enorme campo dell’attività umana alla condanna imposta dai documenti internazionali è impensabile, oltre che strategicamente infruttuoso. La ricostruzione non può essere pensata solo come scintillante attualizzazione di un edificio perduto, frutto di una sostanziale indifferenza nei confronti del passato. Se governata dall’attenzione filologica, dall’attenzione per la continuità con i resti del passato, dalla conoscenza della “lingua” parlata dall’edificio distrutto, la ricostruzione può essere un valore, e non una pratica da condannare. Il sentire contemporaneo ha forse superato lo stadio previsto da Riegl quando preconizzava l’invadenza dell’Alteswert. Oggi, anche grazie a molti esempi di arte e architettura contemporanea è possibile parlare di un valore dell’ibridazione, aprendo così alle possibilità di ricostruzioni che raccontino con mattoni e pietre la propria storia, mostrando lacerazioni e discontinuità, ma accogliendo il compito morale del riannodare i fili interrotti. Se l’inizio compete al Creatore, spetta agli uomini ricominciare.